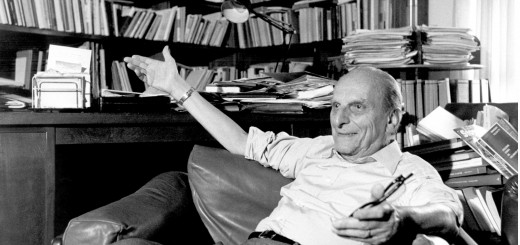Crisi della democrazia nell’era della democrazia come orizzonte?
È dai tempi in cui ero studente che sento parlare di “crisi della democrazia”, un’espressione che mi ha sempre insospettito. Infatti la democrazia a quel tempo non c’era neanche in tutta l’Europa, ad esempio non c’era in Grecia, in Spagna e in Portogallo. Non c’era in tutta l’Europa ad Est di Berlino. Non c’era in America Latina, e quando si affacciava pacificamente, nel Cile di Allende, veniva affogata nel sangue. Non parliamo poi dei regimi che predominavano in Medio Oriente e nel Nord Africa. Adesso in tutti questi paesi la democrazia è diventata un orizzonte indiscusso, dove “orizzonte indiscusso” significa che la democrazia non è più, come è stata per 24 secoli, una fra le varie forme di governo possibili, ma la forma di governo legittima per eccellenza, rispetto alla quale le altre rappresentano gradi diversi per gravità dell’arbitrio istituzionalizzato. Nessuno pensa che la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, l’Olanda, la Spagna o il Regno Unito non siano democrazie solo perchè il capo dello Stato è un re o una regina. Questa ovvietà non è solo un’ovvietà: è la prova di come la democrazia sia passata dall’essere un regime alternativo ad altri all’essere un orizzonte imprescindibile, la forma di governo legittima per antonomasia. E tutto questo mentre sempre si continua a parlare di crisi della democrazia sui giornali, nei convegni, e in televisione.
Quindi inizierò con un’affermazione forte: la tesi della “crisi della democrazia” è fuorviante. Non solo sbatte di peso contro l’evidenza di milioni e milioni di persone che in tutto il mondo hanno rischiato e rischiano la vita per averla, la democrazia, ma soprattutto dirige la nostra attenzione nel punto sbagliato. Machiavelli e Montesquieu hanno entrambi insistito sul fatto che una repubblica o una democrazia non può fiorire né durare nel tempo se impiantata in contesti dove non si è usi al “vivere civile” ovvero dove i cittadini non tengano in considerazione e non posseggano la “virtù” ovvero, tradotto, non posseggano una cultura civica dell’anteporre il bene comune a quello particolare. Una pianta ha bisogno, per attecchire, di suolo e condizioni accoglienti. La stessa pianta, a parità di dotazione genetica, crescerà rigogliosa in un terreno fertile e appassirà se trapiantata in un terreno arido e inospitale. La tesi della “crisi della democrazia” contiene un elemento potenzialmente fuorviante se ci induce a cercare qualcosa di storto nella pianta democratica e non nel terreno sociale, storico, culturale, economico, in cui è chiamata a crescere o nei modi in cui questo terreno è andato cambiando negli ultimi decenni.
Per questo motivo preferisco parlare di “condizioni inospitali” in cui oggi, nelle società del XXI secolo, la democrazia come regime politico è chiamata ad operare – condizioni che già erano inospitali nella seconda metà del XX secolo e lo sono divenute ancora di più oggi. E più che di crisi preferisco parlare di trasformazioni che la democrazia subisce, ad opera del divenire sempre più inospitale del terreno socio-economico e culturale che la ospita, e di auto-trasformazioni che la democrazia può porre in essere per rispondere a queste nuove sollecitazioni.
1. Condizioni inospitali, vecchie e nuove, per la democrazia
Cominciamo con le prime, le trasformazioni del terreno in cui la pianta democratica si trova a vivere. Una delle più sintetiche ma accurate ricostruzioni delle “condizioni inospitali” in cui si trova ad operare un regime democratico inserito in società complesse come le nostre è stata fornita dal costituzionalista americano Frank Michelman, il quale in un suo saggio del 1997 dal titolo How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy, le ha così riassunte:
1) la immensa estensione del corpo politico nelle società moderne, con elettorati di decine e talvolta centinaia di milioni di votanti — una massa che per la sua imponenza nullifica l’ “importanza percepita” della propria partecipazione e incoraggia quella che è stata chiamata da James Fishkin “ignoranza razionale”;
2) la complessità dell’articolazione isti-tuzionale, che rende difficile cogliere tutte le connessioni fra agire politico, conse-guenze del proprio voto ed effetti reali;
3) la anonimità dei processi di forazione della volontà politica, sempre meno me-diati da interazione “in presenza” e sem-pre più catalizzati dai media generalisti prima e ora dalle nuove possibilità del web 2.0;
4) l’irriducibilità del pluralismo culturale, che fenomeni di migrazione di massa e di radicalizzazione religiosa portano ad accentuare, facendo sì che una “politica dell’identità” spesso conflittuale soppianti la relativamente maggiore omogeneità culturale che stava sullo sfondo dei “conflitti distributivi” di gran parte del secolo passato;
5) completerei il quadro di queste condi-zioni inospitali “storiche” con una quinta, la quale concettualmente appar-tiene al quadro teorico che aveva in mente Michelman, ovvero la crescente selettività e differenziazione della cittadinanza su scala domestica: gli stessi processi migratori che radicalizzano il pluralismo portano le nostre democrazie ad allontanarsi sempre più dalla fictio di un coestensività del corpo politico con la totalità dei cittadini “liberi ed eguali” che vivono stabilmente entro un certo territorio e le rendono sempre più simili a quelle antiche, in cui i cittadini optimo jure decidevano democraticamente del destino dei tanti non cittadini.
A queste condizioni avverse che la democrazia si trova da decenni ad affrontare sul terreno delle società stesse in cui è nata, se ne possono aggiungere altre, non così evidenti negli anni ‘80 e ‘90. Ne nomino alcune, per poi soffermarmici brevemente:
6) la finanziarizzazione dell’economia capitalista;
7) l’accelerazione del tempo su scala societaria e globale;
8) la spinta alla aggregazione sovrana-zionale che viene dalla globalizzazione;
9) la trasformazione della sfera pubblica per indebolimento dei media tradizionali;
10) l’utilizzo su ampia scala dei sondaggi e il loro riflesso sulla legittimità degli esecutivi.
Sulla finanziarizzazione: la democrazia ha sempre avuto un rapporto ambivalente e intriso di tensioni con l’organizzazione capitalistica dell’econo-mia, ma è un fatto innegabile che la moderna democrazia rappresentativa non si sia potuta stabilizzare se non in combinazione con un’economia capita-lista. Il capitalismo degli ultimi tre decenni, però, ha dei tratti profon-damente diversi anche da quello postfordista. Il valore del lavoro diminuisce costantemente da mezzo secolo a questa parte in Occidente e questa trasformazione, dovuta a fattori per un verso di razionalizzazione tecnica e per l’altro geopolitici (il mercato globale del lavoro), ha un impatto che va ben al di là delle relazioni capitale-lavoro e della stessa sfera economica. Assistiamo al tramonto del lavoro dipendente come generatore di ricchezza e di prestigio sociale, anche nel terziario, e al tramonto della grande industria fordista: per Detroit il nemico più insidioso non è stato il sindacato, ma Wall Street. Inoltre, la finanziarizzazione dell’economia squilibra ogni rapporto di forza a favore del capitale e della rendita e ridimensiona implacabilmente i redditi, la ricchezza relativa, il potere di acquisto e conse-guentemente anche l’influenza politica dei ceti medi che ruotano attorno al lavoro dipendente. Il lavoro dipendente si fa precario, flessibile, sempre meno retribuito, viene appaltato all’esterno, si desindacalizza, perde capacità di coagulare consenso attorno a sé.
Inoltre la finanza appare più in grado di generare ricchezza che non la produzione e i suoi strumenti si fanno sempre più “virtuali” e sganciati da ogni riferimento reale. Un’azienda vale quanto valgono le sue quotazioni in borsa, e le sue quotazioni in borsa sono funzione delle attese di guadagno “a breve”, non più tanto dei cosiddetti “fondamentali”: (le azioni Fiat hanno oscillato fra 14 e 5 e di nuovo 14 euro nell’epoca pre-Marchion-ne, e oggi sono di nuovo ai minimi, in funzione dell’ipotesi di fusione con Chrysler). Wall Street detta legge alla economia “reale”: sua creazione sono le bolle e i loro scoppi, prima quella delle dot.com, poi quella immobiliare, poi quella dei mutui subprime. Non è difficile scorgere qui una condizione quanto mai inospitale per la democrazia, che già aveva difficoltà ad arginare le dinamiche capitalistiche classiche e soltanto con il New Deal aveva iniziato a farlo.
Inoltre, l’accelerazione del tempo societario preme nella direzione di una verticalizzazione dei rapporti sociali e politici. C’è sempre meno tempo, in tutti gli ambiti, per la collegialità, la deliberazione, la consultazione. Un partito contemporaneo, un’azienda del XXI secolo, ma anche una ONG che voglia stare al passo ed essere riconoscibile nella sfera pubblica, una redazione di giornale che voglia non restare indietro, deve prendere posizione, pronunciarsi, vendere e investire, cogliere un’occasione di visibilità, uscire con una notizia prima dei concorrenti e in un mondo in cui il tempo è il “tempo reale” di Internet. Questa necessità profila in modo più pronunciato la riconoscibilità, la discrezionalità e in ultima analisi il potere del leader politico, del CEO, del responsabile, del direttore di testata – al di là degli sforzi organizzativi e delle culture politiche, aziendali, deliberative che li esprimono. La democrazia non potrà rallentare il tempo della vita sociale nell’epoca di Internet e della connettività globale in tempo reale, però dovrà misurarsi con la sfida di neutralizzarne l’impatto verticalizzante.
Un’ottava condizione inospitale è data dal fatto che la crescente incapacità dello Stato nazione “medio” di misurarsi con le sfide globali – i flussi migratori, la crimi-nalità organizzata, il terrorismo, il mutamento climatico, la sicurezza internazionale – costituiscono una spinta potente all’aggregazione sovranazionale. L’Unione Europea è spesso citata come il battistrada di questo processo, che trova repliche sotto i nomi di ASEAN, Merco-sur, Ecowas, ecc. Questo processo in realtà pone la democrazia di fronte alla necessità di sopravvivere, in forme che rimangono da indagare, alla dissoluzione di quel nesso di nazione, apparato statale, mercato nazionale, cultura, lingua e memorie comuni a cui era collegato il suo fiorire nel moderno sistema degli Stati-nazione. Governance, in contrapposizione a “governo”, soft-law e best practices e benchmarking e moral suasion sono le parole chiave che acquistano centralità rispetto al classico binomio normazione-sanzione, ma è tutt’altro che chiaro quali nuove forme assumerà l’autorialità legislativa dei cittadini (l’obbedire a leggi che si è contribuito a fare), e come si possa distinguere fra governance democratica e governance tecnocratica.
Ancora, la sfera pubblica delle società democratiche sta subendo una nuova trasformazione a pochi decenni di distanza da quel “mutamento strutturale” descritto da Habermas in Storia e critica dell’opinione pubblica. Da un lato l’audience atomizzata dei grandi media generalisti conosce inizi di riaggregazione sotto l’ef-fetto dei social media – Facebook, Twitter, i blog, etc. – e la comunicazione si indiriz-za ora alle decine, al massimo centinaia di persone messe in rete dai social media. Queste reti non sono composte da atomi, ma da molecole sociali costituite da individui che si conoscono. Ritornano gli opinion leader che filtrano la comunica-zione e ne orientano la decodifica. Il grande squilibrio fra emittenti concen-trate, ad alta intensità di capitale, e riceventi dispersi e passivi, comincia ad appianarsi. Dall’altro lato, però, la disponibilità di notizie e informazioni nella rete sta generando una crisi strutturale del giornalismo di qualità affidato alla carta stampata. Il giornale vende notizie già note che si possono ottenere prima e gratuitamente sulla rete. In risposta a questa difficoltà i giornali si settimanalizzano e offrono commenti qualificati a notizie già diffuse nella rete. Tuttavia la domanda rivolta a “commenti autorevoli” è molto più ridotta rispetto alla domanda di notizie fresche, e da qui il declino delle vendite dei quotidiani e la loro minore appetibilità per il mercato pubblicitario. Quindi la democrazia del futuro dovrà fare i conti con una sfera pubblica influenzata da queste trasformazioni.
Infine, un capitolo a parte è rappresentato dall’utilizzo sempre più esteso dei sondaggi a campione per misurare il consenso rispetto agli indirizzi politici adottati dal governo. Perchè questo sarebbe un fattore di potenziale alterazione degli equilibri democratici? Si consideri la percezione della legittimità di un capo di governo, presidente o primo ministro che sia, prima dell’uso massiccio dei sondaggi. La legittimità “percepita” era collegata fondamentalmente all’ulti-mo risultato elettorale. Le sue variazioni nell’intervallo fra due elezioni erano oggetto di mera supposizione e di polemica fra opposti campi politici. Con l’utilizzo regolare dei sondaggi, invece, la “legittimità percepita” assume l’anda-mento altalenante del mercato azionario: sale o scende in funzione di variabili diverse, esibisce trend ascendenti o discendenti, cadute e “rimbalzi”. Queste oscillazioni “in tempo reale” confe-riscono forza e credibilità diversa alle azioni dell’esecutivo e soprattutto, nel quadro della divisione dei poteri, inducono gli altri poteri a reagire diversamente, e dunque a modificare i checks and balances, nei confronti di iniziative dell’esecutivo collocate ai margini della legalità e dei confini giurisdizionali. Una cosa è l’agire di un governo ai limiti della propria sfera giurisdizionale, e la risposta degli altri poteri a questa assertività quando l’esecutivo goda, per ipotesi, del 65% dei consensi, e tutt’altra la loro risposta quando i sondaggi mostrano un calo dei consensi sotto il 50%, il tutto sempre rimanendo per definizione immutato l’ultimo risultato elettorale. Soprattutto, questa nuova condizione assume una problematicità ancora più pronunciata se, considerata la accelerazione del tempo societario, pensiamo che gli esecutivi sono incentivati ad impegnarsi in indirizzi politici che diano risultati non nel lungo periodo, non entro le prossime elezioni, ma nei sondaggi della prossima settimana.
2. La trasformazione del liberalismo e la sopravvivenza della democrazia
Se questo è il quadro delle condizioni sociali e storiche con cui la democrazia deve misurarsi, quali mosse adattive può essa mettere in campo? La democrazia non ha solo “subìto” trasformazioni ma da 30 anni a questa parte si è anche autoriformata, nella visione che il cosiddetto liberalismo politico, a partire dall’opera di John Rawls e Bruce Ackerman fra altri, è venuto elaborando.
Non posso entrare qui nei dettagli, ma scelgo di concentrarmi su una sola operazione di autotrasformazione che il pensiero liberal-democratico ha compiu-to dagli anni ‘90 in poi e che a mio avviso rappresenta la chiave di volta per capire come la democrazia può sopravvivere a condizioni divenute tanto inospitali. Questa chiave di volta ha a che fare con il problema di ripensare la legittimità democratica nel nuovo contesto. Per legittimità democratica intendo un sinonimo di “giustificazione politica”, ovvero la risposta che possiamo dare oggi alla domanda con cui è iniziata 24 secoli fa in Occidente la conversazione intorno al governo legittimo, con la sfida di Trasimaco a Socrate, “non vedi tu che la giustizia è l’utile del più forte?”. Riformulata, la domanda che da sempre è oggetto di attenzione da parte di chi si occupa di filosofia politica da un punto di vista normativo suona così: Che cosa distingue l’uso legittimo del potere dall’uso arbitrario della forza? Ascoltiamo la risposta che John Rawls offre a questa domanda nel 1993. Afferma Rawls:
“Noi esercitiamo il potere politico in modo pienamente corretto solo quando lo esercitiamo in armonia con una costituzione tale che ci si possa ragionevolmente aspettare che tutti i cittadini, in quanto liberi ed eguali, ne accolgano, alla luce di principi e ideali accettabili per la loro comune ragione umana, gli elementi essenziali” (J. Rawls, Liberalismo politico, nuova edizione ampliata, Einaudi, Torino 2012, p. 126).
Come tutte le definizioni, questa formulazione così complessa ci parla attraverso il non-detto. L’apparentemente innocua frase “in armonia con una costituzione” contrasta con “in armonia con il volere dell’ultima maggioranza espressa da regolari elezioni”, con “in armonia con ciò che il Paese desidera, così come attestato da sondaggi attendibili”, con “in armonia con le nostre tradizioni politiche”, con “in armonia con la Bibbia, il Corano o un altro testo sacro”, con “in armonia con il nostro destino storico”, con “in armonia con la nostra idea di moralità”, “in armonia con le nostre possibilità di affermazione vitale”, non dice nulla di tutto questo che è stato pur detto. Dice “in armonia con una costituzione”, che dunque – scritta o non scritta nella forma canonica, come è il caso del Regno Unito – deve esistere. E in armonia con una costituzione tale che ci si possa ragionevolmente aspettare che riceva il consenso di tutti i cittadini – non solo di quelli credenti, di quelli abbienti, di quelli di una certa etnia, di un certo genere, o di un certo orientamento politico – ma di tutti i cittadini, e non de facto, in stile plebiscitario da adunata in piazza Venezia, ma di tutti i cittadini in quanto liberi ed eguali. Ovvero, la costituzione, nei suoi elementi essenziali, e non in tutti i suoi dettagli, deve ricevere – per fungere da parametro della legittimità dell’azione di governo – il consenso di tutti i cittadini in una situazione in cui nessuno è più libero o eguale di altri, e nessuno può premere sui recalcitranti, incentivarli, dissuaderli dal dissentire, ecc. Infine, questo consenso nei confronti degli elementi essenziali della costituzione deve essere dato da tutti i cittadini alla luce di principi ed ideali accettabili alla loro comune ragione umana. Anche qui la definizione parla attraverso il non-detto. Il consenso deve essere dato per ragioni di principio, etiche, non per ragioni prudenziali, ovvero alla luce del timore delle conseguenze politiche di un mancato accordo o di un consenso negato. Una costituzione accettata per timore della guerra civile che potrebbe seguire dalla sua mancata promulgazione può legittimare un modus vivendi, una tregua, un cessate il fuoco, un armistizio con le armi sotterrate in attesa della venuta di qualcuno, ma non l’esercizio stabile e duraturo del potere in un quadro temporalmente esteso. Questo è il nucleo normativo essenziale del liberalismo politico, oltre al richiamo a concetti come la ragione pubblica, il ragionevole, gli oneri del giudizio e molti altri, su cui non posso qui soffermarmi.
Il punto interessante è che questa definizione del potere legittimo, formulata nel 1993, può essere intesa come una risposta auto-trasformativa, da parte della democrazia, alle condizioni inospitali di cui abbiamo parlato.
Due implicazioni sono a mio avviso essenziali.
Primo, Rawls accoglie la proposta ackermaniana di una concezione dualistica della democrazia. L’insieme di condizioni sociali, economiche e storiche sopra elencate fanno sì che sia pressoché impensabile valutare la “rispondenza a giustizia” o legittimità di un ordinamento politico prendendo come metro la possibilità che ogni sua istanza, ogni suo segmento possa godere di una giustifi-cazione esauriente che incontri il con-senso di tutti i cittadini. La definizione di Rawls contiene l’implicazione che nelle condizioni della società contemporanea sopra descritte dobbiamo accontentarci di molto meno: non possiamo pensare che ogni delibera di un qualsiasi consiglio comunale debba rispondere alla nostra idea complessa di una società giusta. Ci saranno sempre, in altri termini, aspetti dell’azione di governo, dell’operato dei magistrati o dell’attività legislativa del par-lamento che un singolo cittadino esperirà come coercitivi e ingiusti nei confronti della sua persona, della sua parte politica o della sua categoria sociale.
Al posto di una illusoria versione del lockeano “consenso dei governati” ne subentra una più sobria che prospetta il costituzionalismo democratico come un doppio livello di giustificazione. Subentra cioè l’idea, tipica della riflessione liberale proposta in We the People da Bruce Ackerman, pienamente accolta da Rawls in Liberalismo politico, che il misurare la rispondenza a giustizia di un ordinamento politico sulla base del suo essere giustificabile di fronte a ogni cittadino ha senso, nel contesto divenuto sempre più “inospitale” delle società complesse, solo per un livello “alto” del diritto e del sistema politico – il livello che coincide con la costituzione, neanche presa nella sua interezza, ma solo nei suoi aspetti principali – mentre per tutti gli atti legislativi, amministrativi e giudiziari di livello “ordinario” la giustificazione consi-ste nella mera conformità al quadro costituzionale (in un quadro, ovviamente, in cui sono all’opera meccanismi di judicial review o controllo costituzionale).
Il che ci conduce all’altra implicazione di questo modello liberale. Non esiste più la centralità del parlamento come luogo privilegiato in quanto presuntamente più prossimo al popolo-sovrano. La branca legislativa, nel suo operare ordinario, è solo una fra tre e non dotata di un particolare valore: la sovranità popolare si esprime in egual misura anche nelle altre. O meglio, la politica “normale” come puzzle-solving dell’intreccio degli interessi, come crocevia di lobby particolariste, può non essere demonizzata perché in essa il “popolo”, inteso tecnicamente come “il titolare della sovranità”, è silente, non già attivo come nell’immaginario giacobino. Il titolare della sovranità non si cura di emendamenti alla legge di stabilità o di leggine ad hoc. Si pronuncia solo sulle revisioni o gli emendamenti alla Costituzione, in sistemi come quello statunitense in cui la ratifica è prevista sempre e il Congresso soltanto propone un emendamento alla Costituzione.
Riassumendo: alle condizioni sempre più inospitali a cui è chiamata ad operare, la democrazia può rispondere rivedendo in direzione dualistico-costituzionalista la sua nozione di legittimità democratica ed aprendo quindi la strada ad una tutela anche giuridica dei suoi cardini fondamentali, i diritti, rispetto allo strapotere di maggioranze elettorali divenute più permeabili alla influenza del denaro e dei media e può rispondere rendendosi capace di funzionare meglio anche su quella scala sovranazionale ove più si esercita la pressione delle nuove condizioni inospitali.
Chiudo quindi con una nota di fiducia. Non si sono mai viste condizioni tanto inospitali per la democrazia come oggi, nelle società complesse, ma la capacità autoriformatrice della democrazia – che è sopravvissuta al passaggio dall’essere tipica delle piccole città-Stato ai grandi stati-nazione della modernità – è più versatile di quella di qualunque altro regime politico.